Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Todi (Perugia) la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ha organizzato una iniziativa culturale nel quadro del Centenario della Grande Guerra. L’iniziativa si è articolata – tra il 28 settembre e il 17 novembre 2018 – in una serie di conferenze -incontri di analisi e approfondimento dei temi storiografici relativi al primo conflitto mondiale, con particolare riguardo al coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori oltre che della cittadinanza tutta.
Il primo incontro si è tenuto il 28 settembre, nella Sala del Consiglio, Palazzi Comunali della città umbra con il titolo “Nulla sarà più come prima”. Hanno introdotto il sindaco di Todi avv. Antonino Ruggiano e l’assessore alla Cultura dott. Claudio Ranchicchio. Relazioni del prof. Giuseppe Parlato, ordinario di storia contemporanea nella Università degli studi internazionali di Roma, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, e del dott. Gianni Scipione Rossi, giornalista e storico, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.
Il 20 ottobre l’incontro è stato sui temi “I cattolici italiani tra patriottismo e fede”, con la dott.ssa Maria Chiara Mattesini, giornalista e storica, Universita’ di Roma Tor Vergata, e “Il dopoguerra dei combattenti: divisioni e stati d’animo”, con la dott.ssa Cristina Baldassini, ricercatrice in Storia delle dot- trine politiche, Università di Perugia. Ha coordinato Gianni Scipione Rossi.
“Quando la letteratura racconta la guerra” il tema del 2 novembre, con la prof.ssa Simonetta Bartolini, docente di letteratura italiana nella Università degli studi internazionali di Roma e con Giuseppe Parlato.
Il programma si è concluso 17 novembre 2018, sul tema “Le conseguenze del conflitto tra scenario internazionale e modernizzazione”. Sono intervenuti il prof. Silvio Berardi, docente di storia contemporanea Università Niccolò Cusano Roma, il dott. Andrea Perrone della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, il prof. Marco Zaganella, docente di storia economica Università dell’Aquila, e Giuseppe Parlato.
____________________________________
Todi 28/9/2018
L’intervento di Gianni Scipione Rossi
Qualcuno di voi potrebbe pensare, per certi versi legittimamente, <basta, perché ancora la Grande Guerra. Sono cinque anni che ne parliamo>.
Il problema me lo sono posto anch’io.
In effetti sono anni che se ne parla e non si può certo dire che il Centenario sia passato sotto silenzio. Sono stati pubblicate decine di libri – talvolta non all’altezza, semplici sintesi o affreschi puramente divulgativi – e il numero di articoli, di mostre, di iniziative credo sia incalcolabile.
Ne valeva la pena? Era necessario? Naturalmente penso di si e non credo che si debba smettere di parlarne dall’anno prossimo, perché i lasciti della guerra hanno condizionato, nel bene e nel male, le vicende politiche, sociali, economiche, culturali dei decenni successivi, la nostra storia di un secolo. E molto c’è ancora da chiarire e capire.
Che se lo diciamo così – un secolo – sembra un tempo lontanissimo, quasi eterno, ma in realtà copre la storia personale e familiare di appena quattro/cinque, al massimo sei generazioni. Si parla di quello che hanno fatto, subito, costruito, sofferto, pensato, i nostri nonni o bisnonni. Se ci si riflette bene non è così lontano.
Poi, naturalmente, questa iniziativa si svolge in questo autunno che, cent’anni va, segnò la fine della Grande Guerra con la Vittoria dell’Italia.
Al 4 novembre manca ormai poco più di un mese. Ne parleremo.
Il problema è come parlarne, della Grande Guerra. Al di là dei fatti d’arme, delle battaglie, dei generali, del ruolo svolto dai protagonisti politici dell’epoca, dalla Monarchia, dagli interventisti ai neutralisti, agli irredentisti. L’elenco degli attori sarebbe lungo e articolato.
La storiografia, come sapete, è sempre in divenire. Chi pretende di aver scritto la parola fine alla ricostruzione e alla interpretazione di un evento non è un bravo storico. La continua revisione è una necessità e un obbligo, sulla base dei documenti e della loro possibile diversa spiegazione.
Revisione non vuol dire revisionismo. Che pure è un vizio ricorrente. Non solo in Italia.
Qualcuno si diverte anche a riscrivere la storia degli altri.
In questi giorni mi ha colpito una notizia. Nell’Austria guidata dal giovanissimo cancelliere Sebastian Kurz, del Partito Popolare, stanno riscrivendo i libri di storia per le scuole, orwellianamente, si potrebbe dire.
Lo hanno scoperto e rivelato Rita Monaldi e Francesco Sorti, su “La Stampa” del 24 settembre, facendo diversi esempi.
Ve ne leggo uno.
In VG3 Neu (per la scuola media, ancora Lemberger editore) il capitolo sul Risorgimento si apre con un’abile premessa: «Nel XIX secolo, ambiziosi uomini di Stato capirono che l’idea nazionale si adattava in modo eccellente al raggiungimento dei loro personali obiettivi politici. Volevano espandere i loro Stati a costo degli altri, e allo scopo utilizzarono come giustificazione l’idea nazionale. In molte parti del mondo ancora oggi si fa politica in modo simile».
Il vero obiettivo dei leader italiani sarebbe stato “dividere l’impero asburgico”.
Cavour, Garibaldi e Mazzini diventano così un piccolo club di ambiziosi, e l’unificazione d’Italia una guerra di aggressione. Proseguono gli autori: «Il Piemonte nella seconda metà del XIX secolo si sviluppò in un moderno ed efficiente Stato-modello. Appoggiò l’idea di una divisione dell’Austria». Insomma, Cavour voleva dividere l’impero asburgico, anziché unificare l’Italia… «Con un’abile politica estera, il regno di Piemonte-Sardegna si guadagnò l’alleanza di Francia, Gran Bretagna e Prussia. L’Austria invece era isolata (…). Quando nonostante ciò rischiò e scese in guerra, le truppe alleate di Francia e Piemone-Sardegna sconfissero l’esercito austriaco, male organizzato, a Magenta e Solferino».
Un resoconto – dicono gli autori dell’articolo e io condivido– che fa a pugni con i fatti storici: a Magenta e Solferino si combatté perché l’Austria aveva imposto ai piemontesi, assai inferiori militarmente ma alleati alla Francia, di disarmarsi entro tre giorni. L’ultimatum non venne rispettato e gli austriaci attaccarono. A Solferino gli eserciti contrapposti erano pressoché equivalenti, gli Austriaci anzi avevano un’artiglieria più consistente, ma la conduzione tattica dei francesi fu vittoriosa.
Direte, che c’entra ora il Risorgimento e come lo vedono o rivedono gli austriaci?
C’entra, perché questa rilettura del Risorgimento è molto simile a quella che in Italia appartiene a una – per la verità non qualificata ma diffusa – corrente storiografica per così dire neo-borbonica, che ha il palese obiettivo politico-culturale di suscitare un risentimento contro l’unità d’Italia, completata cento anni fa. Una corrente che ebbe un dignitoso precursore in Carlo Alianello, e che oggi vive grazie a piccoli epigoni che ricostruiscono le vicende del Regno delle Due Sicilie infarcendo i fatti con quelle che oggi si chiamano fake news.
Ricorderete che in Puglia si è tentato di istituire una <giornata della memoria delle vittime meridionali dell’unificazione italiana>. Le quali naturalmente ci furono, come ci furono i patrioti meridionali vittime della repressione dello stato borbonico.
Il problema è, come sempre, quale uso si fa della storia. Che non dovrebbe essere politico o ideologico.
Non mancano, naturalmente, i nostalgici dello Stato Pontificio. Qualche tempo fa mi è capitato di ricordare quali erano le condizioni del Regno del Papa prima dell’Unità. Lo feci citando una lettera scritta nel 1837 al fratello dal futuro cardinale segretario di stato di Pio IX, Giacomo Antonelli, che all’epoca era delegato – cioè capo della provincia – di una delegazione pontificia che è qui vicino a noi, quella di Viterbo. Dove rimase impressionato dalla <orribile miseria che regna dappertutto, specialmente nella classe povera (braccianti)>.
Tutto questo c’entra con il nostro argomento perché la lettura della Guerra Mondiale ha attraversato due fasi storiografiche.
Dopo la vittoria prevale – ed è abbastanza scontato – la lettura retorica che ne esalta il significato patriottico dell’immane sacrificio del popolo. Non solo dei combattenti delle trincee, ma anche dalle loro famiglie, dal cosiddetto fronte interno. Esalta, questa lettura, il senso di completamento del Risorgimento insito nel ritorno alla Patria unita di Trento e Trieste.
Sottace, naturalmente, gli errori militari, e anche le speculazioni che circondarono la produzione bellica, e non solo.
Non dimentichiamo che durante la guerra e nei mesi successivi vigeva la censura militare, come in ogni altro paese belligerante. Per farvi un esempio, il libroKobilek. Giornale di battagliadi Ardengo Soffici, nella prima edizione Vallecchi del 1919, è pieno di pagine bianche tagliate dalla censura.
Non furono invece censurate nel 1916 queste pagine di Renato Serra, giovane intellettuale del circolo della Voce, partito volontario e morto combattendo sul Podgora il 20 luglio 1915. Problematico, il testo di Serra, in verità, a leggerlo tutto:
La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; (…) non vi aggiunge; non vi toglie nulle. Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. (…)
Sempre lo stesso ritornello. La guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella; per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. (…)
Laggiù in città si parla forse ancora di partiti, di tendenze opposte; di gente che non va d’accordo; di gente che avrebbe paura, che si rifiuterebbe, che verrebbe a malincuore. Può esserci anche qualcosa di vero, finchè si resta per quelle strade, fra quelle case.
Ma io vivo in un altro luogo. In quell’Italia che mi è sembrata sora e vuota, quando la guardavo soltanto; ma adesso sento che può esser piena di uomini come son io, stretti nella mia ansia e incamminati per la mia strada, capaci di appoggiarsi l’uno all’altro, di vivere e di morire insieme, anche senza saperne il perché se venga l’ora. Può darsi che non venga mai: tanto che l’aspettiamo e non è mai venuta! (…) oggi è il tempo dell’angoscia e della speranza.
Siamo comunque molto lontani dalla marinettiana guerra sola igiene del mondo.
Anche se quella sortita di Marinetti va contestualizzata nel clima della Belle Époquee del suo scivolare – a parere del poeta futurista – nel decadentismo.
D’altra parte già nel 1921 usciva il famosissimo Le scarpe al soledi Paolo Monelli sulla guerra degli alpini, che non era certo – come si direbbe oggi – politicamente corretto.
E, per fare un esempio, nel 1935 l’ufficio storico dello Stato Maggiore del Ministero della Guerra poteva tranquillamente pubblicare il diario dell’infermiera volontaria della Croce Rossa Mercedes Astuto, che non nascondeva certo le difficolta:
La mia corsia s’è empita tutta: quaranta letti quaranta operati, un’altra fila di letti anche nel mezzo, quasi tutti addominali e qualcuno cranico. Il lavoro mi spaventa; non ho per aiuto che rozzi piantoni, territoriali passati in sanità, inesperti e taluni niente suscettibili.
Questo per dire che la retorica della Vittoria non impedì la circolazione di riflessioni critiche, neppure durante il governo fascista, al quale si imputa la sacralizzazione della Grande Guerra, che, tuttavia, ci fu anche nella Francia democratica. Come era normale che accadesse.
La retorica prevalse e sarebbe stupido negarlo.
Con il passare dei decenni la retorica rimase ma cambiò segno.
È la fase della rilettura per così dire dal basso della guerra. Protagonisti non sono più i generali e i politici, ma il popolo. Non il popolo dei combattenti delusi che saranno i protagonisti del successo del fascismo. Ma il popolo minuto, con i suoi problemi, le sue paure, i suoi dolori.
Una nuova lettura necessaria, ma che col tempo è sfociata in un rovesciamento della complessa verità storica.
I generali diventano tutti incapaci e felloni. Il popolo non vuole la guerra ma semplicemente la subisce e si arrangia come può. Se si arrivò alla vittoria un anno dopo Caporetto non fu per la capacità di reazione italiana sul Piave, ma per una manciata di reggimenti inglesi. E via di questo passo.
Questi sono i paradigmi prevalenti. Che vengono ammantati di strabordante retorica in un film che molti di voi ricorderanno, e si situa nel filone del cinema neo realista.
È il 1959 quando arriva nelle sale La Grande Guerradi Mario Monicelli, con protagonisti indimenticabili Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Silvana Mangano. Un film che si divide ex aequo il Leone d’Oro al Festival di Venezia con il bellissimo Il generale Della Roveredi Roberto Rossellini.
Grande film La Grande Guerra. E grandissime le interpretazioni di Oreste e Giovanni da parte degli attori.
Ma qual è il messaggio?
Oreste e Giovanni sono due tragici soldati da operetta. Non credono in niente. Cercano solo di evitare i pericoli e la fatica. Sono due vigliacchi. Cercano di scappare vestiti con cappotti asburgici. Solo l’esatto contrario del soldato valoroso della retorica prima maniera. Sono anti eroici e si riscattano in qualche modo solo accettando la fucilazione, decidendo di non tradire dopo le offese di un ufficiale austriaco. Un finale per altro controverso. Furono le associazioni d’arma a premere perché i vigliacchi si riscattassero.
Ma fu proprio così o invece la rappresentazione deve essere più articolata?
Sentiamo una testimonianza un po’ sorprendente, quella di Rudyard Kipling, che nel 1917 inviava dal fronte trentino le sue corrispondenze ai giornali inglesi:
Oltre all’immane sforzo richiesto (…) quello che continua a colpire l’osservatore sul fronte italiano, è l’asprezza delle condizioni in cui tutti operano: dall’austerità spartana dell’ufficio del generale Cadorna (…) al più umile dei mulattieri, che bianco di polvere da capo a piedi, ma senza una goccia di sudore in fronte, arranca sugli erti sentieri montani dietro il suo animale. Si nota un’organizzazione flessibile ed equilibrata al cui servizio tutti si prestano con fervida abnegazione.
Kipling non era al servizio dello Stato Maggiore italiano.
Da una retorica all’altra, forse solo a cento anni di distanza si riesce a dare una lettura equilibrata della Grande Guerra. Anche grazie alle memorie dei soldati. Ormai ne sono state pubblicate migliaia.
E tuttavia il mito della guerra non voluta e solo subita dagli italiani è difficile da superare.
I questi anni del centenario è anche accaduto che in Parlamento sia stata presentata una proposta di legge per la riabilitazione dei disertori.
È un capitolo dolorosissimo. Ne furono fucilati un migliaio.
Vi leggo una testimonianza, di un giovane avvocato combattente sul Carso, Tommaso Petroselli, che fu chiamato a difendere in un processo volante alcuni di loro:
Dei miei difesi, i soldati semplici, furono condannati a vent’anni di carcere, i due graduati alla fucilazione immediata. Sentii mancarmi le forze, mentre i votati alla morte mi si gettarono al collo, implorando che presentassi istanza di grazia alla Regia. Ben sapevo però che in questi casi eccezionali vana era ogni speranza di grazia.
Ci furono, dunque i disertori. Come in tutti gli eserciti. In Francia, per la verità, furono più numerosi. La pena nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie è scontata. Ma una riabilitazione sarebbe a mio parere un’offesa a tutti i soldati che fecero fino in fondo il loro dovere, anche morendo sul campo di battaglia.
È anche accaduto, non più tardi di un anno fa, che qualcuno abbia protestato per la decisione di attribuire a papa Giovanni – parlo di San Giovanni XXIII – il ruolo di protettore dell’Esercito Italiano. Come è possibile – si è detto – che il Papa buono protegga un esercito? Lo si è detto negando il ruolo dei cappellani militari in quella guerra, nella quale operarono per altro anche ministri del culto con le stellette ebrei e protestanti. Si è voluto dimenticare che Giovanni XXIII era stato un cappellano militare e su quella sua opera ha scritto pagine splendide.
Mi fermo qui, ma non prima di avervi letto un’altra testimonianza.
È il 4 novembre 1918. Siamo al Lago d’Ampola, in Trentino.
Alle due fulminea voce. Da soldato a soldato, da baracca a baracca, da vetta a vetta: <Armistizio! Vittoria!>. Poi ancora: <Sul Piave le armate austriache sono in rotta>. I soldati si guardano storditi. Non credono.
Poi s’abbracciano, saltano, gridano, pregano, tacciono, s’appartano, ridono. È una commozione ineffabile che ci prende, ci scuote, c’inebria ed illumina.
Queste parole sono state scritte da un pacato medico militare, non da un esaltato ardito volontario, Filippo Petroselli. Fratello dell’avvocato Tommaso.








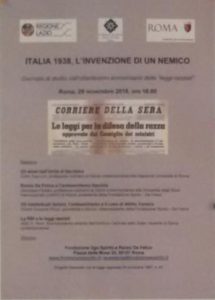 A ottanta anni di distanza dal varo delle “leggi razziali”, la Fondazione, con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio di Roma Capitale, ha organizzato una giornata di studio per ricordare e riflettere su uno dei momenti più oscuri della storia italiana del Novecento. Il convegno, dal titolo Italia 1938, l’invenzione di un nemico, si è tenuto nella Sala della Fondazione giovedì 29 novembre 2018. La giornata ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di studio su vari aspetti del processo di formazione dell’intervento legislativo, sulle conseguenze, sulla storiografia e sulla percezione della popolazione. Di quelle leggi, scrisse Tullia Zevi, «la popolazione in un primo tempo non percepì la gravità». L’iniziativa, pensata anche per coinvolgere gli studenti delle superiori, ha visto gli interventi di Ester Capuzzo, ordinario di Storia contemporanea nella Sapienza Università di Roma, sul tema Gli ebrei dall’Unità al fascismo; di Giuseppe Parlato, ordinario di Storia contemporanea nella Unint di Roma e presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, sul tema Renzo De Felice e l’antisemistimo fascista; di Gianni Scipione Rossi, giornalista e storico, sul tema Gli intellettuali italiani, l’antisemitismo e il caso di Attilio Tamaro; di Aldo G. Ricci, storico e Sovrintendente Emerito dell’Archivio Centrale dello Stato, sul tema La Rsi e le leggi razziali. Il convegno è stato seguito con molto interesse dal pubblico, composto anche da molti studenti. Numerosi gli interventi nel dibattito.
A ottanta anni di distanza dal varo delle “leggi razziali”, la Fondazione, con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio di Roma Capitale, ha organizzato una giornata di studio per ricordare e riflettere su uno dei momenti più oscuri della storia italiana del Novecento. Il convegno, dal titolo Italia 1938, l’invenzione di un nemico, si è tenuto nella Sala della Fondazione giovedì 29 novembre 2018. La giornata ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di studio su vari aspetti del processo di formazione dell’intervento legislativo, sulle conseguenze, sulla storiografia e sulla percezione della popolazione. Di quelle leggi, scrisse Tullia Zevi, «la popolazione in un primo tempo non percepì la gravità». L’iniziativa, pensata anche per coinvolgere gli studenti delle superiori, ha visto gli interventi di Ester Capuzzo, ordinario di Storia contemporanea nella Sapienza Università di Roma, sul tema Gli ebrei dall’Unità al fascismo; di Giuseppe Parlato, ordinario di Storia contemporanea nella Unint di Roma e presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, sul tema Renzo De Felice e l’antisemistimo fascista; di Gianni Scipione Rossi, giornalista e storico, sul tema Gli intellettuali italiani, l’antisemitismo e il caso di Attilio Tamaro; di Aldo G. Ricci, storico e Sovrintendente Emerito dell’Archivio Centrale dello Stato, sul tema La Rsi e le leggi razziali. Il convegno è stato seguito con molto interesse dal pubblico, composto anche da molti studenti. Numerosi gli interventi nel dibattito.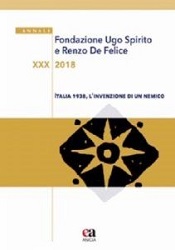 Gli atti del convegno in “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, a. 2018, XXX
Gli atti del convegno in “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, a. 2018, XXX

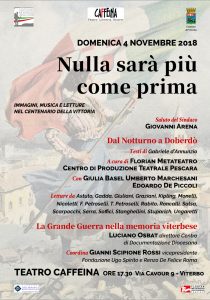 Il 4 novembre 1918 il comandante supremo del Regio Esercito Armando Diaz, dopo l’armistizio firmato a Villa Giusti, diffondeva il Bollettino della Vittoria, che sanciva la sconfitta dell’Impero austroungarico.
Il 4 novembre 1918 il comandante supremo del Regio Esercito Armando Diaz, dopo l’armistizio firmato a Villa Giusti, diffondeva il Bollettino della Vittoria, che sanciva la sconfitta dell’Impero austroungarico.



