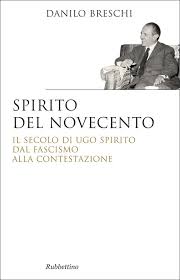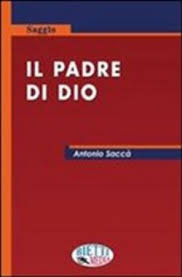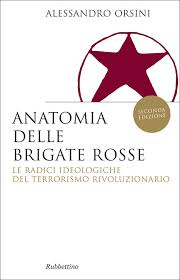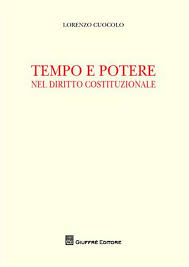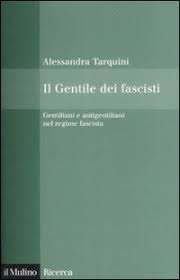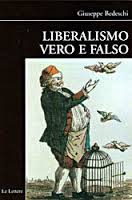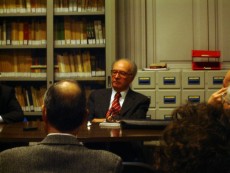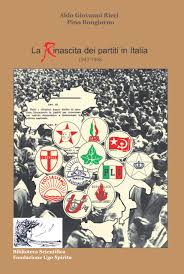Tavola rotonda
Città, regione, nazione: spazi politici e dimensioni territoriali nella storia d’Italia.
Hanno partecipato: Mario Ascheri (Università di Roma Tre), Dino Cofrancesco (Università di Genova), Luca Mannori (Università di Firenze) e Giuseppe Parlato (Presidente Fondazione Ugo Spirito).
Giovedì 25 febbraio 2010, la Fondazione Ugo Spirito ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Città, regione, nazione: spazi politici e dimensioni territoriali nella storia d’Italia“. Hanno partecipato Mario Ascheri (Università di Roma Tre), Dino Cofrancesco (Università di Genova), Luca Mannori (Università di Firenze). Per la Fondazione Spirito sono intervenuti Danilo Breschi e Giuseppe Parlato.
I lavori sono stati introdotti da Danilo Breschi, che ha sottolineato l’interdisciplinarietà dei relatori e dunque dell’approccio seguito per mettere a fuoco il ruolo dalla dimensione territoriale nella storia d’Italia.
L’intervento di Mario Ascheri si è soffermato sull’esperienza tardo medioevale delle città-stato, le cui tracce sono visibili ancora oggi. Secondo Ascheri, ciò è dovuto al fatto che i comuni sono riusciti a sopravvivere, con le loro tradizioni, anche nel periodo degli Stati regionali. Alcune dominazioni, come quella veneziana, non attuarono una politica di assimilazione di questi centri, con il risultato di rafforzare l’identità dei dominati in contrapposizione al potere centrale dominante.
Altri elementi sopravvissuti all’esperienza delle città-stato caratterizzano invece il dibattito politico. La città urbana, infatti, si è sempre caratterizzata per la ricerca di una concordia totale, che esclude il pluralismo degli orientamenti. Il linguaggio politico è così contraddistinto da messaggi universali, generalizzanti, predominanti ancora oggi.
L’intervento di Dino Cofrancesco ha evidenziato che l’esperienza delle città-stato si ricollega alla tradizione democratica, non a quella liberale, perché non ha mai previsto alcuna difesa dei diritti individuali. Si tratta di un aspetto centrale perché quando si riprende il pensiero di Cattaneo e la sua concezione del federalismo, occorre sottolineare che, da buon liberale quale era, l’esperienza a cui egli si ricollegava non era quella delle città-stato ma del Belgio e dell’Olanda. Passando al dibattito attuale, Cofrancesco ha dunque sottolineato che per il pensiero liberale il vero problema non è la localizzazione del centro di potere politico, ma i limiti di questo potere nei confronti dell’individuo.
Luca Mannori ha aperto il suo intervento concordando con Cofrancesco e sottolineando che per secoli il concetto di libertà non è stato concepito nel rapporto tra individuo e Stato, ma nel rapporto tra città-stato o comunque comunità urbana e potere centrale, confondendo il concetto di libertà con quella che in realtà era una forma di autonomia. Nella seconda parte dell’intervento si è invece focalizzato sul persistere della tradizione delle città-stato anche nell’epoca degli Stati regionali. Questo pone un problema storiografico rilevante (ed ancora inesplorato) determinato dalla necessità di comprendere il passaggio da forti identità locali alla nascita dell’identità nazionale.
Infine, Giuseppe Parlato ha confrontato l’esperienza italiana con quella europea, evidenziando che se nel resto del continente gli Stati nazionali si sono formati nel ‘300, in Italia si è cominciato a parlare di nazione solo nel 1848. Ciò è all’origine di una debolezza del sentimento nazionale in Italia, cui fanno da contraltare forti identità locali. Dal Trecento, in Italia, è esistita solo una “nazione letteraria” – nel senso della presenza di una lingua comune utilizzata nella cultura e negli scambi commerciale. La religione cattolica ha invece agito da elemento unificante ma non identitario. In sostanza, per secoli sono mancati elementi che potessero permettere la nascita di un’identità nazionale prevalente sulle identità locali rappresentate dalle città-stato. Rifacendosi agli studi di Rosario Romeo, Parlato ha dunque spiegato che la nascita di uno Stato nazionale nella seconda metà dell’Ottocento fu percepita dalla borghesia come necessaria per la crescita economica e all’avvio del processo di industrializzazione. Al momento di scegliere tra l’opzione federalista ed uno Stato nazionale centralizzato, la classe dirigente optò per quest’ultima tipologia proprio perché cosciente che la debolezza del sentimento nazionale sarebbe stata incompatibile con una strutturazione federalista.
Ascolta l’audio dell’incontro