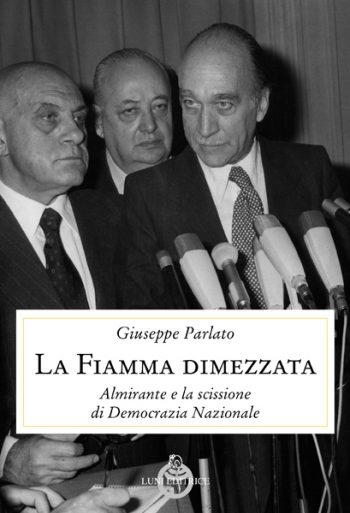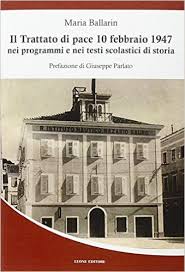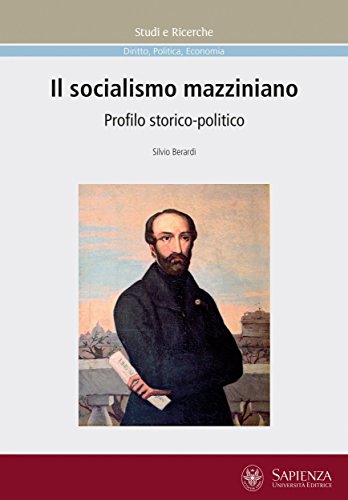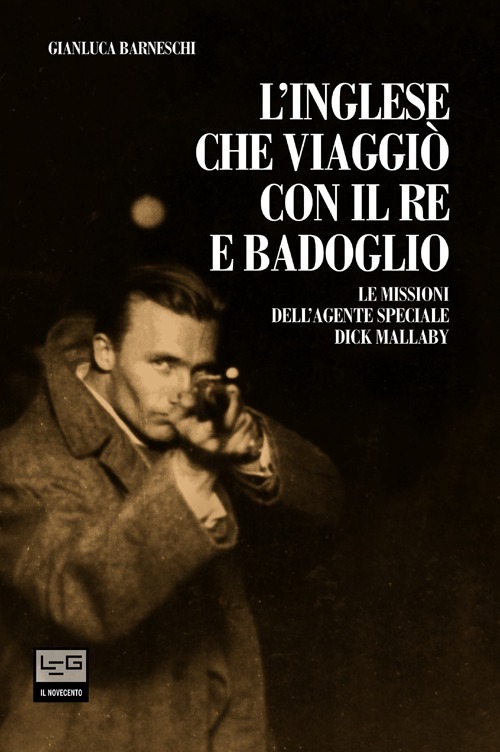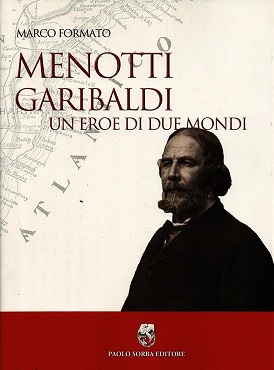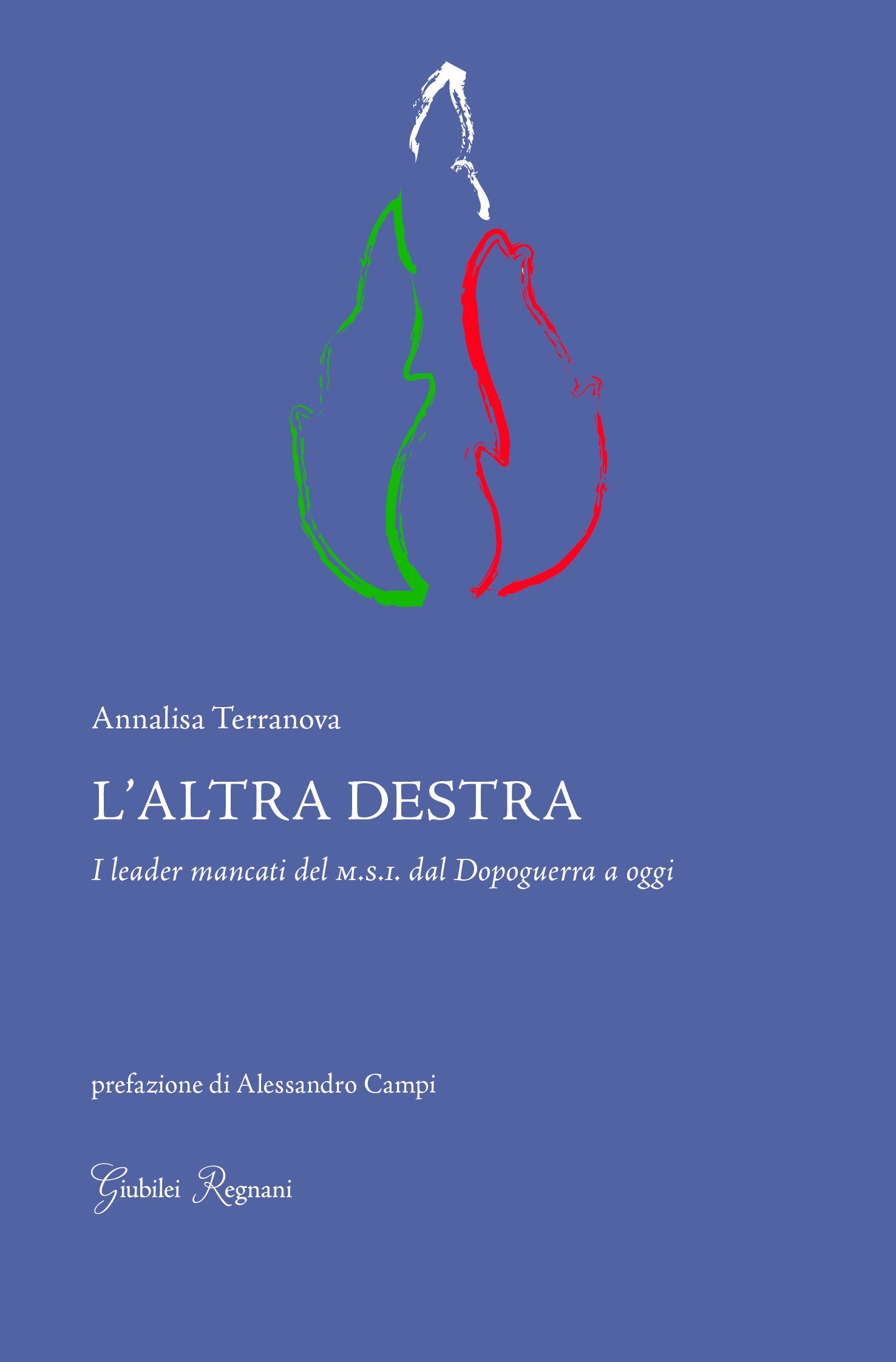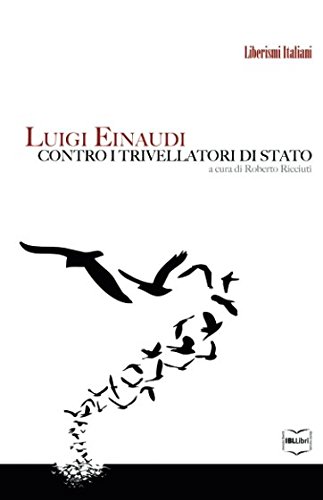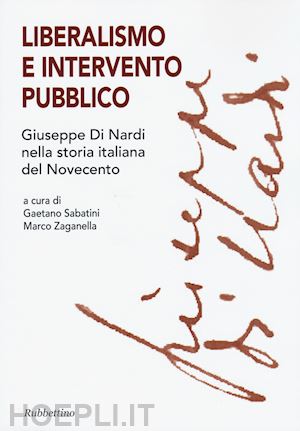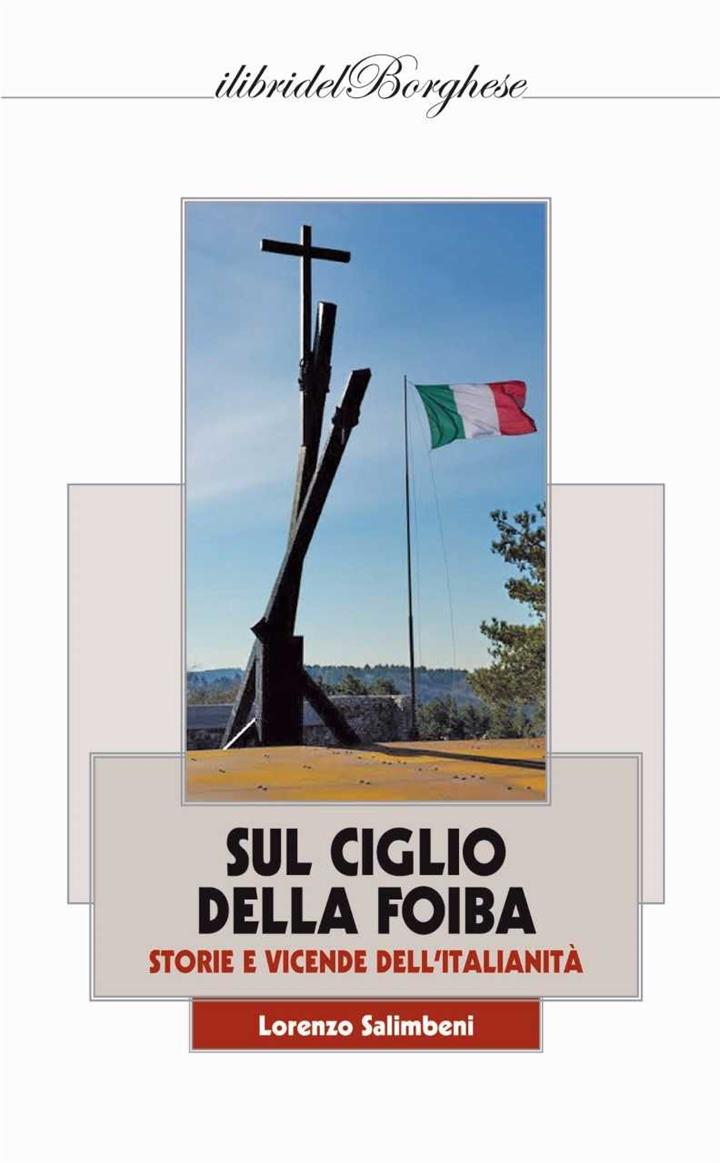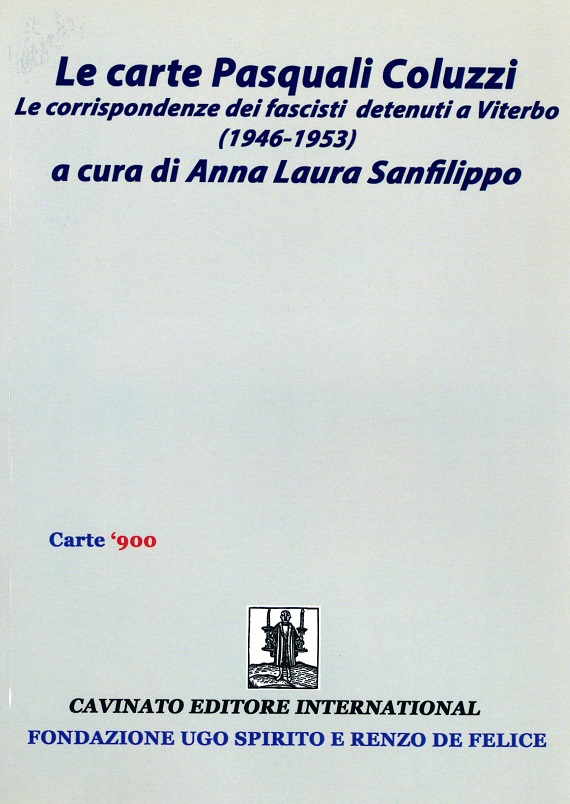Venerdì 31 marzo 2017 è stato presentato il volume di Giuseppe Parlato, La Fiamma dimezzata. Almirante e la scissione di Democrazia Nazionale (Luni Editrice, 2017).
Riportiamo l’articolo scritto da Lorenzo Salimbeni, La ‘Destra dimezzata’ di Democrazia Nazionale
apparso su “Il Giornale d’Italia” del 23 aprile 2017.
Democrazia Nazionale fu un esperimento in anticipo sui tempi oppure un tradimento consumatosi nel 1976 e di lì a poco naufragato? Le ragioni di quella scissione dal Movimento Sociale Italiano risiedono nella dialettica interna o c’è stato un coinvolgimento esterno da parte della Democrazia Cristiana? A queste ed altre domande risponde il professor Giuseppe Parlato nel suo nuovo libro La Fiamma dimezzata. Almirante e la scissione di Democrazia Nazionale (Luni, Milano 2017) che è stato recentemente presentato presso la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice a Roma.
Tra gli intervenuti Gianni Scipione Rossi, giornalista e saggista nonché vicepresidente della Fondazione, che ha evidenziato come Parlato dimostri efficacemente che la Dc non aveva all’epoca alcun interesse a finanziare una scissione di missini “moderati” né e a foraggiare la nascita di un partito di centrodestra. L’unico intento della Balena bianca era infatti quello di riportare il Msi su percentuali contenute.
Marco Gervasoni, ordinario di Storia contemporanea all’Università del Molise, ha poi sottolineato che “nella prima parte del libro si parla di storia missina, onde mettere in evidenza gli antefatti della scissione”. Il professore ha quindi ricordato che negli anni Settanta il MSI fu vittima di una magistratura politicizzata, che insisteva nel metterlo fuorilegge anche se sarebbe stato controproducente. Fatto questo di cui si accorsero invece i comunisti, anche perché oltretutto avrebbe costituito un precedente pericoloso pure per l’estrema sinistra e si sarebbe creato un movimentismo extraparlamentare difficilmente controllabile.
Di notevole interesse, per comprendere la scissione demonazionale, l’ampio preambolo che l’autore del volume ha dedicato al percorso missino dal ’69 in poi, con particolare attenzione alla figura di Almirante. A proposito dei sostenitori della scissione, il professor Parlato ha ribadito che alla Dc faceva comodo un Msi “muscolare e nostalgico”. Ed ha aggiunto che il nostalgismo era l’unico vero collante del variegato mondo missino, su cui incombeva la spada di Damocle della ricostituzione del Pnf.
Ricollegandosi poi alla definizione del Msi come “partito di credenti”, Parlato ha ricordato l’editoriale di Almirante sul Secolo d’Italia del 24 dicembre 1976, in cui denunciò la scissione appellandosi ai credenti, di fronte ai quali ammise di non essersi accorto che una serpe covava in seno ai vertici del partito. La risposta della base fu di fedeltà assoluta e l’esperienza di Dn sarebbe stata clamorosamente bocciata alle urne portando alla rapida dissoluzione del partitino. D’altro canto 1975 e 1976 sono gli anni in cui prese corpo il compromesso storico, che spiazzò un Msi in precedenza decisivo nella fiducia ad alcuni governi e nell’elezione di Presidenti della Repubblica. Ancora una volta, però, un’apertura della Dc a sinistra corrispose ad una crisi nel Msi: “La risposta di Almirante in aula fu identitaria – spiega Parlato – in quanto votò contro il compromesso storico senza prestare il fianco al tatticismo, per cui un voto favorevole missino avrebbe garantito la maggioranza senza i comunisti, i quali avevano assicurato la ‘non sfiducia’ solo se fossero stata determinanti”.
Stimolato dagli interventi dell’appassionato pubblico, l’autore del corposo saggio (320 pagine) ha aggiunto che “la DC era tutt’altro che monolitica, ma la dialettica correntizia ha sempre scongiurato le scissioni: onnicomprensiva come il fascismo, la Balena bianca fu un partito a vocazione maggioritaria, con le caratteristiche politologiche del catch all party”.
Nell’ambiente missino, invece, già al congresso dell’EUR del 1973 c’erano state velleità scissioniste poiché De Marzio non sopportava l’arroccamento nostalgico ed il “rancore dei vinti”: anche Alcide De Gasperi nel 1952, dopo aver incontrato una delegazione missina, aveva compreso che in quel partito l’emotività contava più della ragione. Che poi ci fossero stati contatti dei servizi segreti statunitensi con esponenti missini, oggi è acclarato, ma all’epoca la base ne era all’oscuro e viveva nel mito di Mussolini. Se la scissione diennina coinvolse esponenti della Cisnal (in primis Roberti, che era stato a lungo capogruppo alla Camera), non fu indenne nemmeno “l’attempato vertice dei giovani” (Pietro Cerullo, che aveva da poco rifiutato la vicesegreteria nazionale del partito, Massimo Anderson ed i fratelli Ruggeri), che fece una scelta riformista a discapito del velleitarismo rivoluzionario dell’ambiente giovanile. Anche a causa di questa emorragia “Almirante avrebbe dovuto pescare il quinto in classifica – ha concluso Parlato – per trovare un giovane di sua fiducia al quale affidare il Fronte della Gioventù”.
Lorenzo Salimbeni
Recensioni
Giovanni Tassani, Quando gli ex fascisti tentarono di diventare democratici,
______________________________




[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]