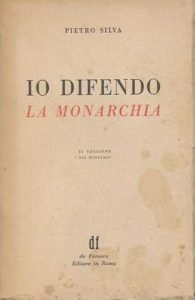Militante e combattente nei ranghi di quel fascismo che è stato definito “di frontiera”, animatore della ricerca storica sull’italianità delle terre dell’Adriatico orientale a supporto dell’associazionismo degli esuli giuliani, fiumani e dalmati e delle sue rivendicazioni, promotore di forme aggregative collaterali alle sigle della diaspora adriatica: intensa e ricca di contatti epistolari, ricerche e scritti è stata la vita di Luigi Papo.
Nato a Grado nel 1922 da una famiglia di sentimenti irredentisti, che ben presto si sarebbe trasferita a Montona, nel cuore della penisola istriana, per dimostrare l’attaccamento che conservava con questa località, in età matura cominciò a farsi chiamare “Papo de Montona”. Dopo aver combattuto in Libia durante la Seconda guerra mondiale inquadrato in una Compagnia Volontari Universitari nei ranghi dei Granatieri di Sardegna, fu poi addetto alle scorte dei treni che dall’Italia raggiungevano la Grecia attraversando i Balcani in cui imperversava con sempre più efficacia il movimento partigiano jugoslavo nazionalcomunista guidato da Josip Broz “Tito”. Colto dal marasma dell’8 settembre ’43 mentre era in licenza in Istria e siccome il padre era figura eminente del fascismo locale, rischiò di venire eliminato durante la prima ondata di stragi nelle foibe che avrebbe cagionato un migliaio di vittime nell’entroterra istriano e a Spalato. Papo scelse quindi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, anche se le province di Udine, Trieste, Gorizia, Lubiana, Fiume e Pola appunto (che comprendeva l’Istria) facevano parte della Zona di Operazioni Litorale Adriatico, una sorta di governatorato militare tedesco in cui i poteri della RSI erano talmente effimeri che non si poté costituire la Guardia Nazionale Repubblicana, bensì la Milizia Difesa Territoriale che rispondeva ai comandi tedeschi locali. Ed è a capo della 3° Compagnia del 2° Reggimento MDT che Papo combatté nei mesi seguenti, durante i quali rivestì anche l’incarico di commissario del fascio nel montonese e di addetto alla propaganda reggimentale (come si può evincere nella sua pubblicazione L’ultima bandiera. Storia del Reggimento Istria, Trieste 2000). Tale reparto si distinse talmente nella lotta antipartigiana che, nelle terribili giornate che seguirono la conclusione delle ostilità al confine orientale italiano caratterizzate dalla conquista jugoslava di Trieste, Gorizia, Fiume ed Istria (Zara era stata già occupata nel novembre 1944), Papo fu associato alle carceri triestine del Coroneo, da cui fu deportato al campo di concentramento di Pestranek. Salvatosi in maniera rocambolesca da una prigionia che per centinaia di detenuti significò morte (la testimonianza di questa vicenda rimane in Pestrane. Diario di un condannato a morte, Gorizia 1984), riparò a Trieste, quindi nella natia Grado, poi a Milano ed infine a Roma, cominciando a denunciare in dei libelli i massacri delle foibe e la violenza titoista: Criminali e liberatori (Roma 1948), Foibe (Udine 1949) ed Insegnamenti dalle foibe istriane (Roma 1951). Utilizzò lo pseudonimo di Paolo De Franceschi (il cognome della moglie), poiché risultava nell’elenco dei criminali di guerra consegnato dalla neonata Repubblica Socialista Federale Jugoslava all’Italia nel corso delle trattative di pace, anche se non venne richiesta la sua estradizione.
Creatosi una vita professionale nei settori gastronomico ed alberghiero, si attivò nell’associazionismo degli esuli dalle terre cedute alla Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 aderendo subito al Comitato Nazionale Venezia Giulia e Zara, poi diventato Comitato per l’Assistenza ai Profughi giuliano-dalmati che si scisse in Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (tuttora attiva e diffusa su tutto il territorio nazionale)e Centro per la tutela degli interesse adriatici (1948), il quale sarebbe in seguito diventato il Centro Studi Adriatici, che trovò ospitalità presso le prestigiose sale del Vittoriano. Già tra i fondatori della testata dell’ANVGD Difesa adriatica, Papo fu direttore del CSA e del suo battagliero bollettino di informazioni, che lui stesso definiva «il solo organo di stampa che si può dire prima italiano, poi, se gli resta tempo, anche democratico». Nel 1963 sorse l’Associazione Nazionale Italia Irredenta, che l’anno dopo assorbì il Centro Studi Adriatici facendolo diventare una sorta di comitato scientifico di questo sodalizio patriottico che ebbe come primo presidente Gioacchino Volpe, al quale succedette il generale Ezio Garibaldi.
Papo avrebbe quindi scritto volumi dedicati alla cittadina in cui aveva vissuto in gioventù (Montona, Padova 1974 e Sólfora. Montona tra realtà e sogno, Trieste 1975) per poi raccontare i primordi dell’associazionismo giuliano-dalmata (E fu l’esilio. Una saga istriana, Trieste 1997) e quindi tornare ad affrontare la questione della pulizia etnica attuata dall’esercito jugoslavo nei confronti della comunità italiana in Istria (L’Istria e le sue foibe: l’Istria tradita, Roma 1999). Tuttavia il lavoro che gli regalò maggiore celebrità si intitola Albo d’oro. La Venezia Giulia e la Dalmazia nell’ultimo conflitto (Trieste 1989 e poi, aggiornato e integrato, 1994): questa poderosa opera raccoglie i nomi dei caduti e dei morti della e nella Venezia Giulia nel corso della Seconda guerra mondiale, con riferimento ai campi di battaglia come alle vittime civili dei bombardamenti, ai deportati della Risiera di San Sabba da parte dei nazisti e a quelli vittime dell’arcipelago concentrazionario jugoslavo. Ancorché incompleto e caratterizzato da alcuni aspetti che discendono dalla forte connotazione politica dell’autore (l’attenzione rivolta ai caduti della Repubblica Sociale Italiana rispetto ai partigiani), tale volume risulta un punto di riferimento imprescindibile per la ricostruzione delle atroci dinamiche politiche che sconvolsero le terre del confine orientale nella fase finale del conflitto, tanto è vero che è stato tenuto in considerazione come fonte dalla commissione che è chiamata ad assegnare ogni anno in occasione del Giorno del Ricordo i riconoscimenti ai parenti e discendenti degli infoibati e delle vittime del terrore “titino”.
Questa produzione libraria e l’intensa attività in ambito associativo lasciarono un cospicuo apparato documentale, che è stato conservato da due istituti di ricerca. Presso l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata di Trieste l’Archivio Luigi Papo consta di materiale documentario vario inerente alle tematiche istituzionali (la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni delle popolazioni italiane dell’Istria, Quarnero e Dalmazia), con alcune documentazioni che provengono da famiglie illustri istriane, una notevole messe di opuscoli, fogli volanti, giornali, molti dei quali del periodo dell’esodo; nel materiale raccolto figura pure una sezione fotografica, di cui è in corso un’opera di digitalizzazione. A Roma, invece, presso la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice il Fondo Papo è stato quasi completamente ordinato e fornisce vari spunti di ricerca, il più immediato dei quali è ad esempio la storia dell’Associazione Nazionale Italia Irredenta, la cui documentazione è raccolta in nove faldoni. Il primo di questi riguarda la fondazione del sodalizio, nel cui direttivo originario figuravano Volpe, come già accennato, in qualità di presidente, Junio Valerio Borghese (già comandante della Decima Mas e attivo all’estrema destra del panorama politico italiano) quale segretario nazionale e tra i probiviri una figura fondamentale nella storia dell’irredentismo adriatico come Giovanni Giuriati, capo di gabinetto di Gabriele d’Annunzio a Fiume nonché presidente dell’associazione Trento e Trieste nell’anteguerra ed organizzatore dei volontari provenienti dalle terre irredente arruolatisi nel Regio Esercito durante la Grande guerra. Le Sezioni provinciali, con cui intercorre una discreta corrispondenza e di cui rimangono gli atti costitutivi, sono presenti in tutto il territorio nazionale e nei loro ranghi riscontriamo con ruoli dirigenziali la presenza di personalità della destra italiana o con trascorsi fascisti (Fortunato Aloi a Reggio Calabria, Piero Buscaroli a Napoli, Italo Tassinari a Forlì, il podestà ed il prefetto ai tempi della RSI Cesare Pagninie Bruno Coceani nonché Riccardo Gefter Wondrich a Trieste, Salvatore Dell’Utri a Caltanisetta), dell’associazionismo della diaspora (il generale Iginio Toth a Modena, Piero Almerigogna e Lino Sardos Albertini a Trieste, Lino Vivoda a La Spezia, Nerino Rismondo ad Ancona, Achille Gorlato, Giuseppe Krekich e Nicolò Luxardo a Padova) ed esponenti della società civile (Fabio Roversi Monaco a Bologna). La corrispondenza ed i ritagli stampa (faldone 4) riguardano non solo tematiche attinenti le foibe e le associazioni degli esuli, ma anche l’irredentismo in Corsica; l’attività dell’Agenzia adriatica di stampa caratterizza il faldone 6, mentre il 9 concerne i pellegrinaggi organizzati alla tomba di Dante a Ravenna e a Firenze nel 1965 (700 anni dalla nascita del “ghibellin fuggiasco”); il quinto faldone raccoglie precipuamente materiale inerente la Famiglia montonese (componente dell’Unione degli Istriani in cui si raccolgono gli esuli da Montona) ma contiene anche il verbale di un’Assemblea Ordinaria dell’Unione degli Industriali Giuliano-Dalmati, una ramificazione poco nota nel panorama dell’associazionismo della diaspora, così come l’Assemblea Costituente Adriatica di cui si riscontrano accenni in altri faldoni.
Se l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia oggi risulta strutturata in comitati provinciali e delegazioni, nei faldoni 10-23 “Personalità: biografie – scritti – fotografie” emergono documenti che riguardano sezioni femminili e di combattenti nei primi anni di esistenza di questa poderosa realtà associativa, che alle origini presentava una forte connotazione di destra. I fascicoli che raccolgono il materiale riguardante ciascuna Personalità contengono non solo scambi epistolari, ma anche articoli di giornale, immagini fotografiche o disegnate e riferimenti a pubblicazioni che hanno attinenza con quel profilo. Numerosi i contributi del colonnello Piero Almerigogna, con il quale ad esempio Papo si sofferma sui complicati rapporti esistenti a Trieste tra il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Istria (che avrebbe dato vita all’Associazione delle Comunità Istriane ma viene presentato come lottizzato dai partiti dell’arco costituzionale) e l’Unione degli Istriani. Interessante la corrispondenza con l’ex gerarca del fascismo nella provincia di Zara prima e nel Governatorato di Dalmazia poi Athos Bartolucci, che all’epoca riveste incarichi a Mogadiscio nell’ambito dell’Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, benché compaia anch’egli nell’elenco dei criminali di guerra ricercati in Jugoslavia. Risultano essere corrispondenti delle iniziative associative e divulgative di Papo Rinaldo Harzarich, il vigile del fuoco che coordinò il recupero delle salme dalle foibe istriane, Geppino Micheletti, il medico che prestò le cure alle vittime dell’attentato di Vergarolla, ma anche irredentisti della vecchia guardia come Manlio Cace e Piero Foscari. Non manca un’invettiva nei confronti di un articolo pubblicato da Il Borghese in cui Giuseppe Prezzolini contestava le tesi di Sorel favorevoli all’annessione della Dalmazia all’Italia.
Al professor Umberto Nani di Mocenigo, direttore del bollettino d’informazione, è dedicato il faldone 24, mentre il 25 ed il 26 riguardano la laboriosa stesura e ristampa di Atto d’accusa, il volume di Andrea Ossoinack che prende le mosse dall’intervento che costui formulò al Parlamento di Budapest il 18 ottobre 1918. Era in corso l’implosione dell’Impero austro-ungarico ed il deputato fumano, al fine di fronteggiare le rivendicazioni croate nei confronti della sua città, si appellò al principio di autodeterminazione dei popoli per Fiume, che in effetti il successivo 30 ottobre con un plebiscito avrebbe ribadito la sua volontà di essere annessa all’Italia. Rispolverare nel dopoguerra questo lavoro, che si fondava sulla radicata autonomia fiumana che nella compagine imperiale asburgica figurava in guisa di corpus separatum nell’ambito della porzione magiara del composito impero, avrebbe dovuto contribuire a rivendicare all’Italia il capoluogo del Carnaro entrato ufficialmente a far parte della Jugoslavia il 15 settembre 1947, giorno dell’entrata in vigore del Trattato di pace. I faldoni 27-30 concernono “Comuni e località della Venezia Giulia = Istria, Carnaro e Dalmazia” (un caleidoscopio di immagini, ritagli di giornale e spunti dedicati a queste terre diventate jugoslave), il 31 presenta il materiale delle terre irredente conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato e negli ultimi tre emerge ancora documentazione sulle associazioni degli esuli.
Una nuova numerazione caratterizza le 13 buste della sezione “Rassegna della stampa del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste” che spazia dal 1957 all’aprile 1962 e fornisce uno spaccato del delicato inserimento del capoluogo giuliano nel tessuto politico ed economico della Repubblica italiana dopo l’insediamento dell’amministrazione civile risalente al 26 ottobre 1954.
Un fascicolo raccoglie, invece, articoli di giornali e dossier riguardo la Risiera di San Sabba, dalle cronache del processo a carico degli aguzzini nazisti che ivi torturarono e deportarono partigiani ed ebrei ai contributi di chi cercava di ridimensionare cifre e tragicità di questo campo di prigionia. Lo Schedario Caduti e Albo d’oro contiene, infine, parte del materiale attinto per la redazione della succitata corposa opera, mentre figura ancora uno scatolone 7 da ordinare.
Quanto è stato qui presentato può risultare utile nella ricostruzione della storia delle associazioni degli esuli giuliano-dalmati, un argomento che sulla scia dell’istituzione del Giorno del Ricordo (L. 92 del 30 marzo 2004) ha acquisito interesse, ricevendo una prima trattazione a cura della giornalista Rosanna Turcinovich-Giuricin in …e dopo semo andadi via. L’associazionismo degli esuli istriani fiumani e dalmati: cenni storici dal 1947 ad oggi, Gorizia, 2014. La prima disamina scientifica risiede nel poderoso volume di Luciano Monzali Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, Venezia 2015, pp. 527-687, laddove il direttore della Società di Studi Fiumani Marino Micich si è concentrato sulle prime forme aggregative di questo microcosmo nel saggio Incontro all’esilio. L’associazionismo degli esuli istriani, fiumani e dalmati durante la seconda guerra mondiale e nei primi anni del dopoguerra (1943-1949) in Fiume. Rivista di studi adriatici (nuova serie), n. 31, Anno XXXV, N. 1-6/2015. Il fondo Papo può arricchire questa panoramica raccontando le prospettive neoirredentiste e la battaglia culturale che egli condusse, ma anche i rapporti che questo battagliero operatore culturale intrattenne con le sigle associative che mantennero in vita nei loro comitati e raduni la memoria delle catastrofi delle foibe e dell’esodo in un’epoca in cui era diventato tabù parlarne in seguito alla rottura di Tito con Stalin nell’estate del 1948.
Lorenzo Salimbeni
da “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, a. 2018, XXX, pp. 179-184.











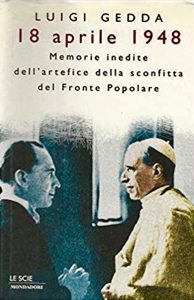 Su questa linea, che Malagodi e Togliatti, da punti di vista poi non così differenti, definirono
Su questa linea, che Malagodi e Togliatti, da punti di vista poi non così differenti, definirono 










 <
< Solo nel
Solo nel