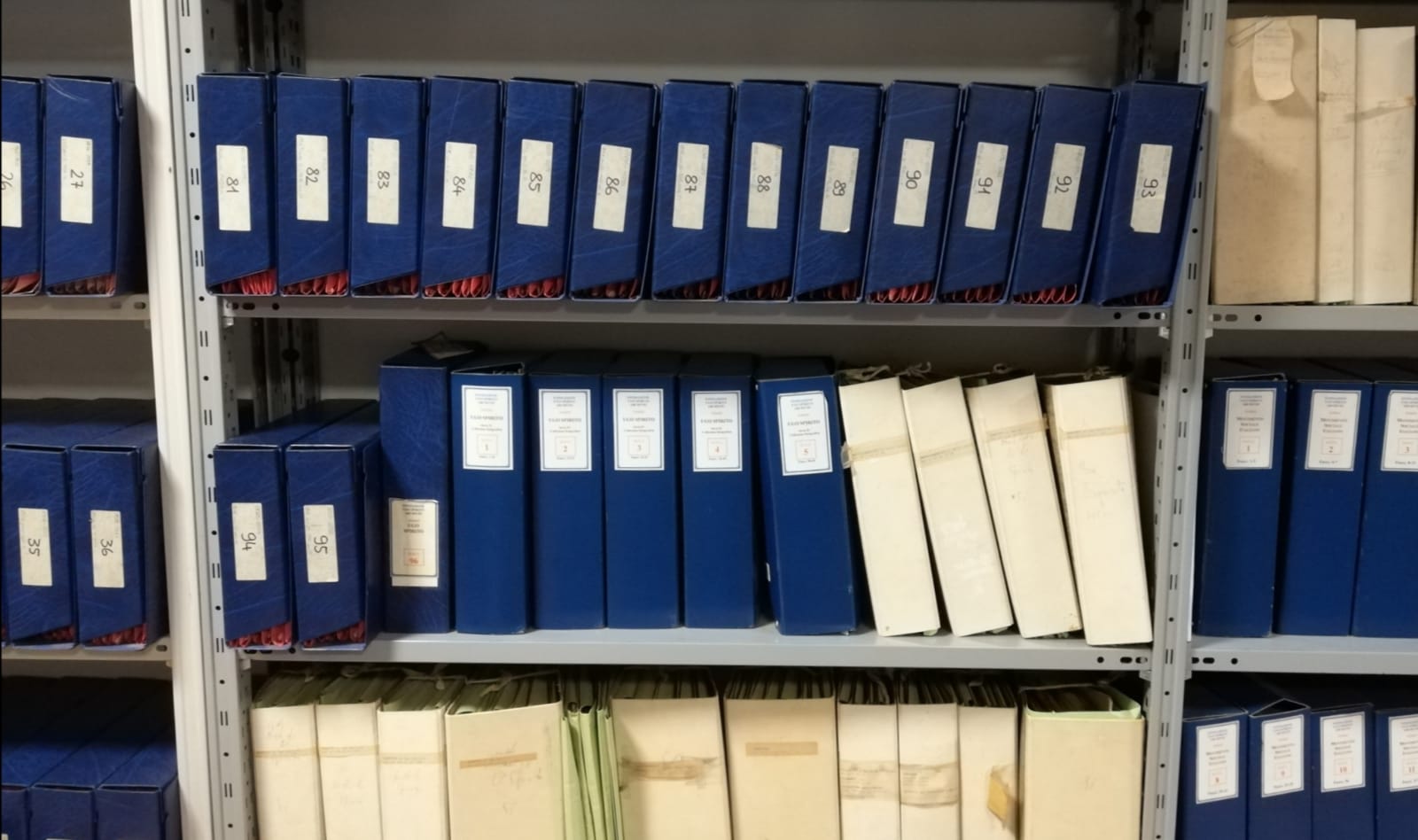di Leonardo Varasano

Il cimitero monumentale di Perugia
Tra le specificità storiche e sociali italiane rientra anche un livello di contrapposizione lacerante e singolarmente alto. La storia d’Italia, a ben vedere, sembra infatti condensare due nazioni, per buona parte ostili nei ricordi e inconciliabili nei progetti. Fattori divisivi di spiccatissima natura politico-ideologica hanno prodotto e perpetuato contrapposizioni in serie. Tutta la vicenda del paese può in fondo essere caratterizzata da una lunga, corrosiva teoria di coppie di opposti: monarchici/repubblicani, laici/cattolici, interventisti/neutralisti, fascisti/antifascisti, comunisti/anticomunisti.
In questa forte propensione alla «divisività» – alla traduzione in forma permanente e patologica delle inevitabili, fisiologichefratture proprie di ogni storia nazionale –, un ruolo di particolare rilievo è rivestito dalla radicale polarità che ha contrapposto fascisti e antifascisti. Anche dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il fascismo è stato a più riprese immaginato come un pericolo incombente: se ne è paventata la possibilità di rinascita, se ne è denunciata la minacciosa sopravvivenza in varî ambiti e in varie forme. Un fatto storico «morto» e «irresuscitabile», limitato – secondo l’interpretazione defeliciana – ad un dato momento storico, racchiuso tra il 1919 e il 1945, ha finito per diventare un elemento centrale del discorso pubblico e della mobilitazione politica dell’Italia repubblicana. Non solo: la presunta, ineliminabile perennità del pericolo fascista è riuscita a rendere plausibile una perenne, strutturale necessità dell’antifascismo, legando fascismo e antifascismo in un binomio strettissimo, così largamente accettato da divenire il sostrato di un senso comune di massa. La potenziale, continua sopravvivenza del fascismo, a lungo addebitata anche all’esistenza e al ruolo della Democrazia cristiana, ha dunque portato ad una funzionale necessità dell’antifascismo. Il paradigma fascismo/antifascismo è stato, a ben vedere, il paradigma ideologico originario della Repubblica, in grado di resistere e rinnovarsi nel tempo. Con esiti divisivi,dolorosi e, come ha rilevato Francesco De Gregori, decisamente parossistici: il nostro paese ha ancora «un grosso problema a parlare di fascismo» – così si è espresso il cantautore romano, nel 2016, intervenendo alla presentazione del volume Mio padre era fascista, di Pierluigi Battista – perché «da noi la riconciliazione non c’è ancora stata» e «persino a una riunione di condominio se a uno gli gira, può dare a un altro del “fascista” usando quel termine come un insulto».
La tenace difficoltà del discorso pubblico italiano a storicizzare il Ventennio, è un tema di persistente attualità. Da più parti si continua a pensare secondo la dicotomia fascismo/antifascismo, nel solco di una strisciante, irriducibile guerra civile della memoria. Eppure questa lacerante contrapposizione tra antifascismo e fascismo (inteso, nel tempo, in una serie di significati enormemente dilatati e metapolitici) avrebbe potuto ben presto essere se non superata almeno attutita, in modo tale da provocare un’eco meno duratura e meno dannosa. Ci fu infatti chi, nell’immediato dopo guerra, tentò una sollecita pacificazione, un avvicinamento di buon senso nel nome della nazione italiana, dell’ideale risorgimentale e delle necessità della ricostruzione. Forse – si può pensare – non si sarebbe assistito ad unaimmarcescibile contesa ideologica, se solo si fosse dato seguito e concretezza ad una piccola-grande iniziativa, finora dimenticata e nascosta dalla polvere, avvenuta nell’immediato dopoguerra in quella che era stata la “capitale della rivoluzione fascista”, la città fascistissima per eccellenza da cui era partita la marcia su Roma. Forse, nel 1947, un lungo, complesso e doloroso capitolo di storia italiana avrebbe potuto chiudersi proprio a Perugia, proprio nello stesso luogo in cui era stato concretamente aperto nel 1922. Forse avrebbero potuto prevalere le ragioni della fraternità, della riconciliazione, dell’unione nel nome della Patria. Forse. Non è dato sapere: si tratta solo di un’ipotesi controfattuale, poiché la vicenda italiana ha avuto, com’è noto, un’evoluzione diversa, vivendo nel solco del binomio fascismo/antifascismo. Le buone intenzioni – manifestate in una temperie storica avvelenata dai frutti amari della dittatura e della morte della patria – fallirono. Cionondimeno quell’episodio che poteva contribuire a cambiare il corso degli eventi merita di essere conosciuto, ricordato, compreso nelle ragioni profonde. Quelle sì, immortali.
1. «Gli italiani agli italiani», una corona di alloro simbolo di fraternità e amor patrio
All’alba del 1947, con l’Italia ancora ricoperta di macerie fumanti, lacerata nello spirito e nella carne, Perugia fu teatro di un singolare e positivo esperimento di riconciliazione tra partigiani ed ex fascisti, oggi presso che misconosciuto.
A prendere l’iniziativa furono Corrado Sassi – classe 1923, antifascista, il partigiano “Zuavo” della banda “Francesco Innamorati” operante nei boschi sopra Deruta – e l’ex combattente della Repubblica sociale italiana Bruno Cagnoli, uomo dall’«intelligenza acuta e sensibile». A soli venti mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale, con la prospettiva di una difficile ricostruzione affidata al primo governo De Gasperi – un governo di unità nazionale di cui ancora facevano parte Dc e Pci insieme –, i due giovani, all’insaputa di tutti i partiti, ma con l’indirettosostegno di altri uomini di buona volontà, promossero una manifestazione semplice e clamorosa al contempo. Nel primo, freddo giorno del 1947, quasi a simboleggiare l’inizio di una nuova era, una cesura della Storia, un centinaio di perugini «che fino al giorno prima si sarebbero volentieri sbudellati l’un l’altro», decise di lasciarsi alle spalle il fardello dei rancori, si radunò in piazza Piccinino, nel cuore del capoluogo umbro, e di lì, in rigoroso silenzio, raggiunse il cimitero monumentale. Arrivati al camposanto, partigiani ed ex fascisti parteciparono ad una Messa di suffragio officiata da Padre Angelini; poi raggiunsero il monumento ai caduti di tutte le guerre e lì deposero una corona di alloro, con nastro tricolore, recante la significativa scritta, a caratteri d’oro, «Gli Italiani agli Italiani»; quindi sostarono per un po’, muti, «davanti a molte croci» di entrambe le fazioni politiche, prima di coprire la ghirlanda funebre con una bandiera nazionale. La cerimonia, arricchita dai discorsi di Luigi de Florentis per i partigiani e di Mario Fettucciari per gli ex fascisti, fu infine suggellata da una solenne stretta di mano con cui i componenti delle due schiere cessarono di essere nemici per diventare semplicemente avversari. […]
Leonardo Varasano, Il capodanno perduto del 1947. Una tentata pacificazione tra partigiani ed ex fascisti nel nome degli ideali risorgimentali
Il testo completo del saggio in “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, n. 1, a. 2019, nuova serie, a. XXXI, pp. 191-206
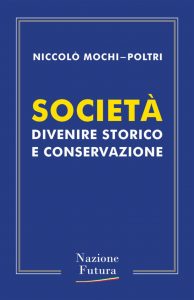 Niccolò Mochi-Poltri, Società. Divenire storico e conservazione, Introduzione di Franco Cardini, Nazione Futura, Roma-Cesena 2018//
Niccolò Mochi-Poltri, Società. Divenire storico e conservazione, Introduzione di Franco Cardini, Nazione Futura, Roma-Cesena 2018//


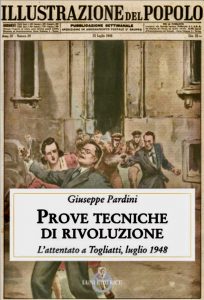 Giuseppe Pardini, Prove tecniche di rivoluzione. L’attentato a Togliatti, luglio 1948, Luni Editrice, Milano 2018//
Giuseppe Pardini, Prove tecniche di rivoluzione. L’attentato a Togliatti, luglio 1948, Luni Editrice, Milano 2018//
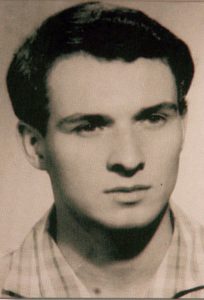

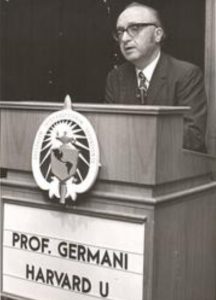 El texto que presentamos (“Ceti e generazioni alla vigilia della Marcia su Roma”) forma parte del Fondo documental de Gino Germani, custodiado por la Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice. Este sociólogo ítalo-argentino (1911-1979) ha sabido cosechar, al menos hasta ahora, más interés entre públicos latinoamericanos que europeos. Sin embargo, buena parte de sus preguntas e intuiciones mantienen una inocultable vigencia a ambos lados del Atlántico. Si en el caso de la Argentina, país en el que, quizás, su inter vención en el campo cultural haya resultado más prolífica, nos enfrentamos al desafío de desestabilizar ciertos clichés con los que suele asociarse su figura (por ejemplo, como mero “importador” de la sociología funcionalista), en el caso de Italia el reto es atraer la atención sobre su trabajo. Paradójicamente, el éxito de su trayectoria latinoamericana parece haberlo relegado, frente a algunos ojos, al papel de sociólogo estricta y estrechamente ocupado en asuntos exóticos. Por el contrario, su trajín de (doblemente) exiliado lo convierte, para miradas más dispuestas a romper con el eurocentrismo, en un sociólogo universal. Al decir del filósofo latinoamericano Eduardo Grüner (2010) la periferia, de la que (a su modo) Germani hizo su punto de vista, constituye una perspectiva privilegiada, pues desde allí puede observarse el todo (por caso, la modernidad capitalista), la parte (por caso, lo que otrora se denominaban los “países semi-coloniales”, “periféricos” o “dependientes”) y la relación entre ambos.
El texto que presentamos (“Ceti e generazioni alla vigilia della Marcia su Roma”) forma parte del Fondo documental de Gino Germani, custodiado por la Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice. Este sociólogo ítalo-argentino (1911-1979) ha sabido cosechar, al menos hasta ahora, más interés entre públicos latinoamericanos que europeos. Sin embargo, buena parte de sus preguntas e intuiciones mantienen una inocultable vigencia a ambos lados del Atlántico. Si en el caso de la Argentina, país en el que, quizás, su inter vención en el campo cultural haya resultado más prolífica, nos enfrentamos al desafío de desestabilizar ciertos clichés con los que suele asociarse su figura (por ejemplo, como mero “importador” de la sociología funcionalista), en el caso de Italia el reto es atraer la atención sobre su trabajo. Paradójicamente, el éxito de su trayectoria latinoamericana parece haberlo relegado, frente a algunos ojos, al papel de sociólogo estricta y estrechamente ocupado en asuntos exóticos. Por el contrario, su trajín de (doblemente) exiliado lo convierte, para miradas más dispuestas a romper con el eurocentrismo, en un sociólogo universal. Al decir del filósofo latinoamericano Eduardo Grüner (2010) la periferia, de la que (a su modo) Germani hizo su punto de vista, constituye una perspectiva privilegiada, pues desde allí puede observarse el todo (por caso, la modernidad capitalista), la parte (por caso, lo que otrora se denominaban los “países semi-coloniales”, “periféricos” o “dependientes”) y la relación entre ambos. La crisi del primo dopoguerra fu l’espressione di un profondo “spostamento” di tutti gli strati sociali e specialmente delle generazioni più giovani – sul piano psicologico, economico, politico e sociale. Anche se fortemente aggravato da caratteristiche proprie dello sviluppo storico dell’Italia, si trattava di un fenomeno comune a molti paesi. Due componenti strettamente intrecciati sono la sua radice. Il più visibile, il trauma della guerra, si inseriva in un processo di lunga durata. Al vertice della piramide sociale, la crescente concentrazione tecnico-economica e l’incipiente trasformazione della classe politica con l’emergere dei primi partiti di massa. Alla base, una potente spinta verso la conquista dei pieni diritti, nell’ordine politico, economico e sociale, in cui erano coinvolte tutti gli strati popolari, compresi gli agricoli. Al centro infine, il declinare di settori arcaici, il sorgere di nuovi, e soprattutto, il contraccolpo dei mutamenti ai due estremi. Per i ceti medi, minacciati dall’alto e dal basso, non si trattava solamente di perdite economiche, ma anche di potere politico e di prestigio. La guerra aveva accelerato il processo: l’immersione delle classi popolari nella vita nazionale, culminata politicamente con il suffragio universale e lo spettacolare aumento dell’organizzazione sindacale, si rendeva socialmente più visibile con la partecipazione attiva di settori fino allora del tutto marginali.
La crisi del primo dopoguerra fu l’espressione di un profondo “spostamento” di tutti gli strati sociali e specialmente delle generazioni più giovani – sul piano psicologico, economico, politico e sociale. Anche se fortemente aggravato da caratteristiche proprie dello sviluppo storico dell’Italia, si trattava di un fenomeno comune a molti paesi. Due componenti strettamente intrecciati sono la sua radice. Il più visibile, il trauma della guerra, si inseriva in un processo di lunga durata. Al vertice della piramide sociale, la crescente concentrazione tecnico-economica e l’incipiente trasformazione della classe politica con l’emergere dei primi partiti di massa. Alla base, una potente spinta verso la conquista dei pieni diritti, nell’ordine politico, economico e sociale, in cui erano coinvolte tutti gli strati popolari, compresi gli agricoli. Al centro infine, il declinare di settori arcaici, il sorgere di nuovi, e soprattutto, il contraccolpo dei mutamenti ai due estremi. Per i ceti medi, minacciati dall’alto e dal basso, non si trattava solamente di perdite economiche, ma anche di potere politico e di prestigio. La guerra aveva accelerato il processo: l’immersione delle classi popolari nella vita nazionale, culminata politicamente con il suffragio universale e lo spettacolare aumento dell’organizzazione sindacale, si rendeva socialmente più visibile con la partecipazione attiva di settori fino allora del tutto marginali.



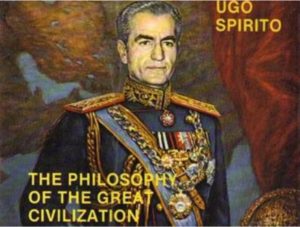

 //di Alessandra Cavaterra
//di Alessandra Cavaterra
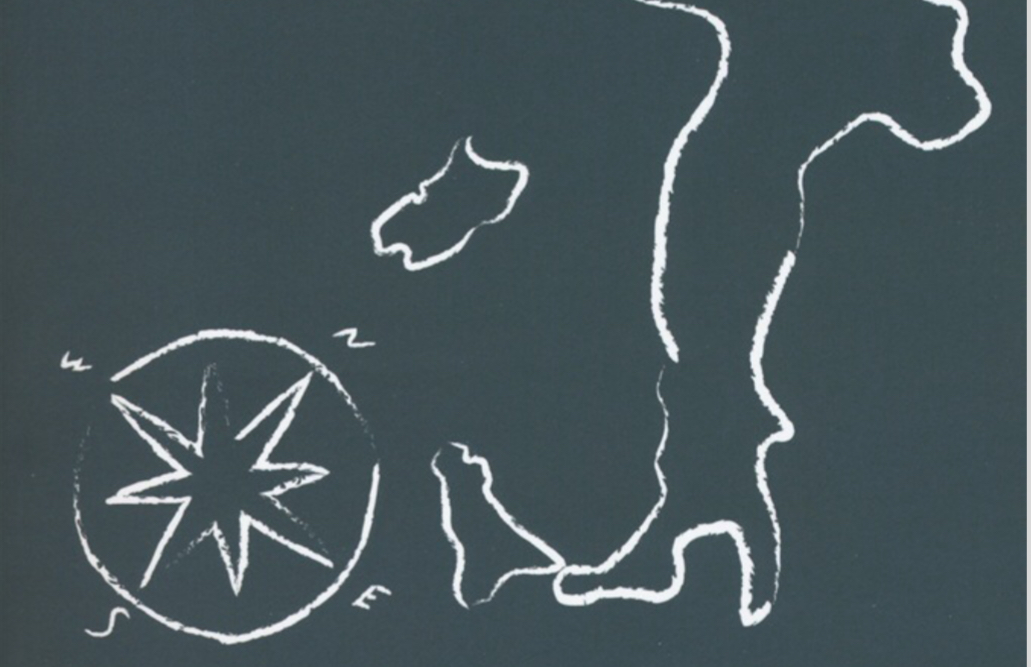
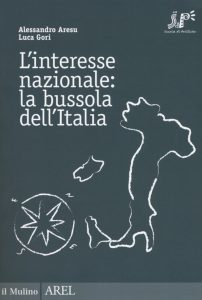 //È apparso nelle librerie il volume L’interesse nazionale: la bussola dell’Italia, pubblicato dalle edizioni Il Mulino e realizzato con il contributo di un analista e consigliere scientifico di Limes, Alessandro Aresu, e di un diplomatico di carriera, Luca Gori, che hanno analizzato il problema, sottolineando le difficoltà che si incorrono nel promuovere l’argomento e ricordando come sia assolutamente necessario superare questo limite di fronte a un ritorno del tema nelle agende governative e nel dibattito pubblico internazionale.
//È apparso nelle librerie il volume L’interesse nazionale: la bussola dell’Italia, pubblicato dalle edizioni Il Mulino e realizzato con il contributo di un analista e consigliere scientifico di Limes, Alessandro Aresu, e di un diplomatico di carriera, Luca Gori, che hanno analizzato il problema, sottolineando le difficoltà che si incorrono nel promuovere l’argomento e ricordando come sia assolutamente necessario superare questo limite di fronte a un ritorno del tema nelle agende governative e nel dibattito pubblico internazionale.